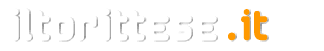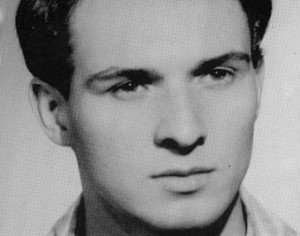Sarebbe buona norma che prima di criticare un testo lo si leggesse con un minimo di attenzione. Mi sorprende che invece Carlo Rovelli — per giunta uno scienziato di vaglia — si sia fatto prendere dalle sue emozioni e dai suoi pregiudizi obiettando a cose che io non ho mai scritto.
A differenza di quanto egli mi attribuisce non ho mai scritto, infatti, che «la nostra società deve essere guidata da un sistema di valori e dalle regole dettate (corsivo mio) dai comportamenti socialmente ammessi». Ho scritto di condividere l’opinione della cancelliera Merkel secondo cui chi immigra da noi deve integrarsi «nel sistema di valori, di regole e di comportamenti socialmente ammessi che vigono da noi». Come si vede una cosa ben diversa da quella immaginata da Rovelli (non ho mai pensato né scritto, cioè, che debbano essere i comportamenti socialmente accettati a dettare le regole. E mi chiedo: può specialmente un uomo di scienza permettersi una simile leggerezza? Può farne l’architrave del suo ragionamento senza accorgersi dell’errore?).
Il fraintendimento ora detto, chiamiamolo benevolmente così, consente a Rovelli, che vi insiste più e più volte, di prodursi in una lunga discettazione sulla necessità che le nostre società siano «regolate dalle leggi, non da sistemi di valori e giudizi individuali su cosa siano comportamenti socialmente ammessi», sdegnandosi adeguatamente del fatto che io, invece — secondo l’opinione che egli manipolando le mie parole mi attribuisce — auspicherei il contrario.
Evviva le leggi, abbasso i valori: questo è la sostanza del punto di vista di Rovelli, convinto, si capisce benissimo, di esprimere in tal modo una visione altamente democratica e razionale come si conviene a un vero scienziato. Peccato però che in questo caso si tratti di un punto di vista e di una visione sbagliati. Le leggi di una qualunque società, infatti, derivano da null’altro che dai suoi valori. E da dove altro se no? Salvo rarissimi casi tra le une e gli altri non vi può essere che una sostanziale coincidenza: pena, altrimenti, la non osservanza delle prime o la necessità di dure misure repressive per ottenerne il rispetto. «Le leggi vengono discusse dalla politica» scrive Rovelli. Appunto: e su che cosa egli crede che verta tale discussione, che cosa crede che rispecchi la sua conclusione in un testo legislativo, se non ciò che pensa, che crede, che spera chi vive in quella società? Cioè i suoi valori? Valori che poi, naturalmente, non possono non influenzare in modo significativo anche i comportamenti socialmente ammessi. In ogni società — e tanto più direi nelle società democratiche — tra leggi, valori e comportamenti c’è una sorta di necessaria circolarità, di necessaria corrispondenza (esattamente come io avevo scritto nella frase da Rovelli manipolata).
L’evidente scarsa dimestichezza di Rovelli con tali argomenti si manifesta in pieno quando egli si mette a parlare della cultura in generale e di quella della nostra penisola in particolare (ma in fin dei conti lo capisco: non si può possedere in eguale misura la bibliografia sui neutrini e quella sulla storia d’Italia). Cultura è una parola complessa, dalle molte accezioni; un po’ come filosofia. Ebbene Rovelli parla di cultura come chi a proposito di filosofia parlasse allo stesso modo della filosofia idealistica e della «filosofia del parmigiano», cioè non distinguendo la sostanziale differenza tra gli usi diversi dello stesso termine. Certo che «ogni cultura non è mai unica», come un po’ alla buona scrive Rovelli. Certo che ogni cultura degna di questo nome si forma attraverso la confluenza nel proprio alveo di influssi e ibridazioni. Ma l’alveo è decisivo, per l’appunto. E ogni alveo è diverso da un altro. Dunque, credere che l’Italia sia un esempio preclaro di multiculturalismo solo perché della sua identità fanno parte cose diverse come il Rinascimento toscano e l’Illuminismo milanese, o perché Peppone e don Camillo votavano partiti opposti, è un’idea di un’approssimazione e di un’ingenuità che un minimo, ma proprio un minimo, di preparazione sull’argomento sarebbe stata sufficiente ad evitare. La verità è che non ci si può mettere a sentenziare su queste cose in modo impressionistico, basandosi su un buon liceo e sulla lettura dei giornali. È come se io mi mettessi a disquisire sui «buchi neri» o a dire la mia sugli anelli di Saturno.
Egualmente è di un’ingenuità e di un’approssimazione intellettuali da far cadere le braccia credere, come il mio interlocutore crede, che la cultura italiana di oggi sia profondamente diversa da quella dei nostri nonni. Cioè, bisognerebbe dedurne, che la cultura di un Paese — quella vera, quella profonda, frutto di innumerevoli stratificazioni a cominciare da quella religiosa — cambi ogni settanta, ottanta anni. Non è così. Ciò che cambia è semmai il costume, caro Rovelli, il costume, non la cultura, non i tratti dell’identità e dei suoi valori di fondo. Sono cose assai diverse, come lei sa, e la conoscenza dovrebbe consistere innanzi tutto nella capacità di distinguere.
Che dire infine di New York, Shanghai o Mumbai additate in queste righe quali eden di una «tolleranza serena delle diversità», della «convivenza pacifica», di «un senso civico comune», di «una nuova identità plurale»? Ma ha mai provato chi scrive tali cose a passeggiare di notte nel Bronx o a tenere un comizio antigovernativo su un marciapiede del Bund? Ed è mai venuto a conoscenza che, certamente non nei quartieri centrali di quella grande città, ma sicuramente in moltissime zone dell’India, essere cattolico è, per esempio, un’impresa a rischio che si può pagare con la vita, ovvero, per dirne un’altra, che lo stupro delle giovani donne è pratica diffusa, molto spesso ancora oggi impunita? Ma andiamo, di che cosa stiamo parlando?
La verità è che il multiculturalismo di cui parla Rovelli e che suscita la sua entusiastica adesione non ha molto a che fare con nulla di reale, con la storia, con le culture, con i problemi reali (da lui infatti del tutto ignorati perché, immagino, attribuiti a pure «superstizioni» che il progresso prima o poi cancellerà). È un multiculturalismo da vip lounge aeroportuale, un multiculturalismo da campus di Yale, da prestigiose summer school riservate ai «migliori studenti», come egli scrive. Un mondo levigato e confortevole dove regna il politically correct che lo obbliga a credere che esistano leggi disincarnate dettate da una morale universale mentre — che bello! — in una strada da qualche parte «i giovani di tutto il mondo si parlano ». È il mondo al riparo del mondo dove solo può vivere in un cieca autoreferenzialità l’idillio buonista di tante élite intellettuali dell’Occidente, avvolte nel compiacimento dei privilegiati che neppure sospettano di esserlo. Ernesto Galli della Loggia, Il Coriere della Sera, 13 gennaio 2016
 Mattia Feltri, figlio di Vittorio, ha scritto e pubblicato un libro-verità sulla vicenda di Tangentopoli il cui titolo, emblematico, è “93″, perchè è la storia di un anno, il 1992, che travolse una intera classe dirigente accusata di ogni nefandezza. Mattia Feltri non la riabilita ma scava in profondità su quella vicenda tratteggiando i profili dei protagonisti e in qualche modo riequilibria colpe e ragioni di tutti. Il padre Vittorio non ci sta ed essendo stato a suo tempo tra i giornalisti che si schierarono senza se e senza ma dalla parte dei giustizialisti dell’epoca, ha scritto una recensione del libro del figlio estremamente dura sul Giornale. Gli ha risposto a stretto giro di posta il figlio sulla Stampa. Pubblichiamo nell’ordine i due articoli, non senza consigliarvi di acquistare e leggere il libro di Mattia Feltri. Serve a comprendere ciò che realmente accadde in quell’anno, tra il 1992 e il 1993, nel nostro Paese. g.
Mattia Feltri, figlio di Vittorio, ha scritto e pubblicato un libro-verità sulla vicenda di Tangentopoli il cui titolo, emblematico, è “93″, perchè è la storia di un anno, il 1992, che travolse una intera classe dirigente accusata di ogni nefandezza. Mattia Feltri non la riabilita ma scava in profondità su quella vicenda tratteggiando i profili dei protagonisti e in qualche modo riequilibria colpe e ragioni di tutti. Il padre Vittorio non ci sta ed essendo stato a suo tempo tra i giornalisti che si schierarono senza se e senza ma dalla parte dei giustizialisti dell’epoca, ha scritto una recensione del libro del figlio estremamente dura sul Giornale. Gli ha risposto a stretto giro di posta il figlio sulla Stampa. Pubblichiamo nell’ordine i due articoli, non senza consigliarvi di acquistare e leggere il libro di Mattia Feltri. Serve a comprendere ciò che realmente accadde in quell’anno, tra il 1992 e il 1993, nel nostro Paese. g.